Gli unici azzurri che resistono alla calce sono alcuni preparati chimici proposti a cominciare dall'Ottocento. In precedenza gli azzurri erano stesi a secco, con tempere di vario tipo.
AZZURRO di COBALTO
(Blu imperatore, Blu di Leyden, Blu porcellana, Blu reale, Blu di Thenard,
Blu di Vienna, Oltremare di cobalto, Oltremare d'oca) è ossido di cobalto
e di alluminio, Al2O3CoO, fatto conoscere da Thenard nel 1802. Ha buon
potere coprente e resistenza elevata a tutti gli agenti. Non è attaccato
dalla calce, per cui il suo uso a fresco è sicuro. Col bianco sangiovanni
dà belle gradazioni luminose. Col giallo di cadmio si possono comporre
verdi stabili. Prova di qualità: una parte di colore in dieci parti di
acido ossalico, bollire e lasciare riposare; l'acido deve restare incolore.
Se diventa azzurro denota presenza di blu di Prussia, se odora di uova
marce significa che c'è dell'oltremare.

BLU CERULEO
(Azzurro celeste, B. Celino, B. di cobalto e stagno, B. di Hopfner, Cilestro)
E' stannato di cobalto, CoO-SnO2 in uso dalla seconda metà dell'Ottocento.
Limitato potere coprente ma ottima resistenza.
BLU ERCOLANO

AZZURRITE
(Azzurro d'Alemagna, Azzurro di Biadetto,
Azzurro citramarino, Azzurro della Magna, Azzurro di montagna, Azzurro
di rame, Azzurro tedesco, Azzurro di vena naturale, Blu armeno, Cendree,
Ongaro) è carbonato basico di rame allo stato naturale che viene estratto
dalle miniere di rame assieme alla malachite. E' tinta poco stabile: con
l'umidità si trasforma in verde malachite. Nella pittura a fresco annerisce,
per cui è sempre stata stesa a tempera sopra una base rossa composta generalmente
da due parti di sinopia e una parte di nero di vite (MORELLONE). Già noto
ai Romani che lo chiamavano "lapis armenius". Giotto la usò soprattutto
nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Nel '500 era preferita al lapislazzuli
perché più economica, a volte mescolata con esso e spesso confusa.

Natività e annuncio ai pastori, Giotto 1303-1306 ca.Padova Cappella degli Scrovegni
AZZURRO
OLTREMARE ARTIFICIALE
(A. di Norimberga, Blu francese, Nuovo
Bleu, Oltremare francese, Oltremare di Guimet) Silicato di alluminio e
solfuro di sodio, annunciato da Guimet nel 1827. Non resiste alla calce,
ma, se mescolato alla terra verde, dà più garanzia.
AZZURRO OLTREMARE NATURALE
(A. di Baghdad, A. di Pietra, Blu di garanza) E' ricavato dal lapislazzuli,
pietra preziosa di colore azzurro composta essenzialmente di lazulite
(silico-alluminato di sodio). Già noto ai Romani, venne usato soprattutto
nei sec. XIV e XV dopo che ne vennero perfezionati i metodi di preparazione.
Il nome "oltremare" deriva dal fatto che questo pigmento veniva importato
via mare dall'Oriente. Marco Polo nel "Milione" scrisse che nell'Afganistan
"vi è una montagna ove si cava l'azzurro ed è lo migliore ed il più fino
del mondo". Nella pittura a fresco generalmente sbiadisce, perciò è sconsigliabile.
Sono rari gli esempi di resistenza a fresco: cantoria della Cappella di
San Stanislao nella Basilica inferiore di S. Francesco ad Assisi dipinta
da Puccio Capanna e cappella Tornabuoni di Santa Maria Novella di Firenze
dipinta da Domenico Ghirlandaio. In generale esso fu steso sull'intonaco
secco con una tempera, ma, dato il suo alto costo, raramente venne impiegato
per affreschi (ove veniva normalmente sostituito con l'azzurrite) e la
sua quantità ed il suo impiego venivano espressamente pattuiti fra committente
e pittore. Per constatare le contraffazioni lo si tratta con acido nitrico:
se è puro si riduce in cenere, se invece lascia tracce azzurre si è in
presenza di cobalto o di blu di Prussia.
AZZURRO di SMALTO
(A. di Boemia, A. di Slesia, A. di Svevia, A. di Vetro, Blu di Eschel,
Blu imperiale, Blu di Sassonia, Blu Ungheria, Smaltino, Vetro di cobalto,
Zaffro) E' vetro fuso con composti di cobalto e poi macinato. Usato dagli
antichi nella decorazione ceramica e dai Romani a fresco. Citato da Vitruvio
e descritto da Plinio con i nomi di vitrum e silix caeruleus. Usato in
affreschi medievali, ebbe largo impiego dal secolo XVI in poi, fino a
che fu sostituito con l' A. di COBALTO. Lo smaltino non ritiene l'acqua,
perciò, se lo si trova su superfici affrescate, esso fu dato a tempera
sull'intonaco già asciutto. E' possibile soffiarlo sopra l'intonaco fresco,
però, data la sua trasparenza vitrea, non possiede forte potere tingente.
BLU di PRUSSIA
(B.
Acqua, B. Amburgo, B. di Anversa, B. di Berlino, B. di Braunschweig, B.
Cinese, B. di Erlanger, B. di Ferro, B. Lavabile, B. Minerale, B. Nuovo,
B. Olio, B. di Sächsisch, B. di Sassonia, B. Williamson, B. Zwickauer)
Ferrocianuro ferrico proposto da Diesbach nel 1721 perfezionando il B.
di Parigi inventato da Milory nel 1704. Ha forte potere tingente, ma non
resiste alla calce. Fu usato da affrescatori dell'Ottocento, ma steso a
tempera.
CENERE d'AZZURRO
(Cenere d'Oltremare) E' ricavato dai residui della lavorazione dell'Oltremare.
Citato dal Baldinucci che aggiunge "dal lapislazzuli di cattivo colore".
Risulta usato dal Foppa per gli affreschi della Cappella Averoldi al Carmine
di Brescia.
CRISOCOLLA AZZURRA
E' un minerale assai raro di azzurrite combinata al quarzo. Fu usata a
fresco nell'antichità.
INDACO
(Blu indiano) Colorante vegetale ricavato dalla "indigofera tinctoria".
Noto da sempre, usato soprattutto nella tintura dei tessuti. Cennini lo
consiglia su muro in sostituzione dell'azzurrite, ma non resiste alla
calce. Leonardo lo ha adoperato nell'Ultima Cena di Milano. Il prodotto
sintetico, in commercio dal 1880, è più resistente.
BIANCO SANGIOVANNI
È il più efficace ed è costituito da calce spenta trattata in modi particolari.
Secondo Cennini la calce va messa in un catino d'acqua per otto giorni;
ogni giorno si cambia acqua e si mescola, poi si fa asciugare al sole
e si conserva. In questo modo la calce può anche trasformarsi in CaCO3
e va sempre benissimo. Secondo Armenini si fa bollire del fiore di calce
bianchissima schiumandola accuratamente; dopo averla lasciata raffreddare
la si essicca al sole su mattoni e si conserva fuori del contatto dell'aria.
Un altro procedimento tramandato dagli operatori consiste nel mettere
in un sacco di juta dei sassi appena tolti dalla fornace e lasciarli esposti
in luogo umido per diversi mesi.
Dato come sottopittura rende trasparenti e luminose le tinte sovrapposte (Tomba di Vulci al Museo Torlonia a Roma). Questo bianco è senz'altro il più idoneo per l'affresco, ma è possibile lavorare con il latte di calce e anche con altri bianchi a base di CaCO3 sia minerali:
B. di ALABASTRO, B. di BORGOGNA, B. di BOUGIVAL o BIANCONE, B. di CHAMPAGNE, B. di MARMO, B. di MEUDON, B. di MORAT, B. di ORLEANS, B. di ROUEN, B. SANTO, B. di SPAGNA, B. di TROYES, B. di VIENNA, CRETA di SPAGNA, MARMINA, MELINO, PARETORIO, POLVERE di MARMO, TERRA di VENEZIA
sia di origine animale: B. di GUSCIO, ottenuto dalla macinazione di gusci d'uovo. B. di CONCHIGLIA o B. di OSTRICA o B. PERLA, dato dalla frantumazione di conchiglie.

E' ossido di titanio, TiO2, entrato in uso dopo il 1920. E' un ottimo bianco, ma va steso sull'intonaco dopo averlo impastato con bianco sangiovanni.

BIANCO di PIOMBO
Carbonato basico di piombo
2PbCO3 . Pb (OH)2 E' tra i colori più antichi,
detto anche Biacca, Bianco d'argento, Bianco di Cremnitz, Bianco neve,
Bianco di Krems, Cerussa, Melino, Psimizio. Occupa un posto nella storia
dell'affresco perché fu usato spesso nei secoli XIII e XIV, ma il tempo
lo ha annerito, per cui deve essere assolutamente escluso dalla tavolozza
dell'affreschista.
Alcuni esempi di annerimento si osservano nella basilica di S. Francesco
ad Assisi: affreschi del Maestro di S. Francesco nella chiesa inferiore,
del Cimabue (Crocifissione) e degli aiutanti di Giotto (colonne tra i
riquadri) nella chiesa superiore.
Cennini lo sconsiglia esplicitamente, ma il suo impiego fu molto diffuso
anche nel Quattrocento (Baldovinetti a S. Miniato). Lo stesso Leonardo
lo usò nel Cenacolo mescolato all'azzurrite per formare la base a cui
sovrapporre l'oltremare.
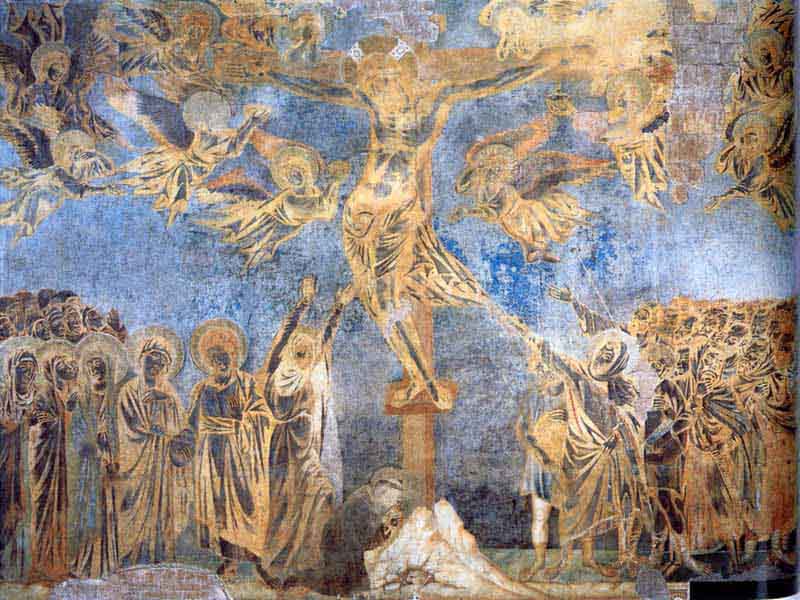
Crocifissione, Assisi - Transetto Basilica Superiore 12771280, Cimabue (Firenze 1240/1245 - Pisa 1301/1303)
Buone tutte le terre, sia naturali che calcinate.
BRUNO
di BERGAMO
chiamato o identificabile anche con Colcotar, Rosso di Marte, Rosso
Pompeiano
BRUNO
d'INGHILTERRA
citato dal Baldinucci che lo definisce "color rosso per fresco"
BRUNO
di MARTE
è giallo di Marte calcinato, noto anche coi nomi di B. di FERRO, B. d'
OSSIDO, B. d' OCRA
BRUNO
TRASPARENTE
o B.
di VERONA o B. di VIBERT è terra verde calcinata
BRUNO
VAN DYCK
quello naturale è la TERRA di CASSEL che ha preso il nome dal pittore
che ne fece grande uso; quello artificiale è solfato di ferro calcinato
ed è chiamato anche B. INGLESE o B. di SVEZIA
CAPUT MORTUM
terra composta di ossido di ferro e solfati di calcio
MORELLO o MORELLONE
Con questo termine sono indicati:
- un minerale a base di ossido ferrico
- una mescolanza di ocra rossa + nero di vite
- un'ocra molto calcinata e in questo caso prende anche il
nome di PAVONAZZO
di FERRO.
Usato soprattutto nella pittura murale medievale come fondo preparatorio
a fresco per l'azzurro applicato successivamente a tempera.
o di COLONIA, BRUNO VAN DYCK. È la tinta naturale più scura per l'affresco. E' composta al 90% di sostanze organiche (torba e lignite) più ferro, silicio, alluminio. Si estrae da giacimenti composti dalla millenaria trasformazione di sostanze vegetali ma può essere anche preparata riscaldando a 300° radici e corteccia di faggio. Venne usata a partire dal XVII sec. e venne chiamata "terra di Colonia" e "terra di Cassel" perché veniva estratta soprattutto da giacimenti situati presso queste città, ma, a partire dal XVIII sec., prevalse il nome "bruno van Dyck" perché questo pittore ne fece un largo uso.

TERRA d' OMBRA
È argilla con composti del ferro e del manganese. In uso dal Rinascimento.
Il suo appellativo deriva dalla sua efficacia a rendere le ombre, oppure,
secondo alcuni, dall'Umbria dove si cavava anticamente. Oggi in commercio
vi sono polveri provenienti dalle isole mediterranee. La Terra d'Ombra
Naturale soffre la luce e bisogna usarla con toni scuri. Quella Bruciata
ha maggiore stabilità e buona coprenza.

Tutte le OCRE sono ottime per l'affresco, inoltre:
GIALLO
di CADMIO
Solfuro di Cadmio, CdS, usato dal 1829. Molto efficace e solido. Si trova
in quattro gradazioni: chiaro, medio, scuro e limone. Quest'ultimo non
resiste alla calce. Evitare di mescolarlo con Terra di Siena bruciata,
Terra d'ombra, Rosso indiano, Violetto di cobalto. Buoni composti con
Azzurro Cobalto e con Verde Smeraldo. Prova di genuinità: una parte in
quattro parti di acido nitrico deve formare una soluzione lattiginosa
con zolfo galleggiante. Se la soluzione è grigia e si deposita in verdastro,
non è buono.

GIALLO CADMIO ORO

GIALLO di CROMO
(G. di Baltimora, G. di Parigi, G. Spooner, G. di Colonia, G. di Leipzig,
G. Nuovo) E' cromato di piombo, PbCrO4, proposto da Vaquelin nel 1798.
Di tonalità variabile dal giallo limone all'arancio a seconda della grandezza
delle particelle. Utilizzabile in affresco tenendo presente che l'alcalinità
della calce lo trasforma in cromato basico rossastro
GIALLO di MARTE
detto anche OCRA ARTIFICIALE composto artificiale di ferro e di
alluminio, usato dalla metà del sec. XIX
GIALLO di VETRO
è vetro colorato a fuoco con piombo e stagno, indicato per l'affresco
dal Baldinucci e dal Borghini, ma, essendo insolubile in H2O, va soffiato
sulla malta o mescolato con essa
GIALLORINO
(o Giallolino) Colore naturale estratto da zone vulcaniche, composto di
stagno e piombo e perciò chiamato anche Giallo di Stagno e Piombo. Lomazzo
cita un G. di Alemagna e uno di Fiandra; Baldinucci lo dice "portato dalla
Fiandra"; Borghini cita un G. di Venezia. Cennini lo indica come buono
per l'affresco, ma in realtà non si può usare. E' possibile imitarlo mescolando
giallo di cadmio con ocra gialla e bianco sangiovanni. La più antica testimonianza
di Giallorino su pittura murale (a tempera) è data da Jacopo da Verona
(sec. XV) nella Chiesa di S. Salvatore a Donaustauf in Germania.
ORPIMENTO
(Giallo di Arsenico, Giallo Cinese, Giallo Reale, Giallo Ubriaco) E' trisolfuro
di arsenico, As2S3, prodotto dai terreni vulcanici, infatti il Baldinucci
lo definisce "giallo di miniera di zolfo" e aggiunge che l'O. ARSO, cioè
calcinato, fa parte dei rossi. Leonardo l'ha adoperato nel Cenacolo e
il Cennini lo consiglia per l'affresco, ma non resiste.
Fra i neri artificiali vanno bene:
NERO
di MANGANESE
biossido
di manganese, usato dall'Ottocento.
NERO di MARTE
o NERO d'OSSIDO ottenuto dalla calcinazione di idrossido di ferro.
NERO di CARBONE
Ottenuto dalla carbonizzazione di legni a venatura stretta (quercia, rovere,
faggio). Si trova su antichi affreschi, ma sempre dato a secco misto a
tempera, in genere d'uovo.
NERO di QUERCIA
Succo della quercia "Jotta concina" Si trova dato a tempera negli affreschi
romani.
TERRA NERA di VENEZIA
Carbonato di calcio con ferro e manganese, molto resistente alla luce
e all'aria, ma deve essere data a colla.
Per l'affresco sono ottime tutte le ocre, argille molto diffuse di varie tonalità a seconda della quantità di ossido di ferro e di sali contenuti:
OCRA CHIARA, GIALLA, GIALLO FIORE, DORATA, CALDA, SCURA, o a seconda
della provenienza: ROMANA, di SIENA, di VERONA, d'ITALIA, FRANCESE, TEDESCA,
ATTICA.
La finezza e la purezza del colore dipendono dalla cura nella macinazione
delle terre. Per provarne la genuinità si mette un pizzico di terra in mezzo
bicchierino di alcool etilico puro; questo deve restare limpido, se si colora
rivela la sofisticazione con aniline.

Sono buoni tutti quelli di origine minerale:
è un miscuglio di sinopia e sangiovanni. E' la tinta per incarnati.
TERRE
BRUCIATE
cioè arroventate (ROSSO VENEZIANO, TERRA di SIENA, TERRA d' OMBRA, TERRA
TREVIGIANA, TERRA di VERONA), con gradazioni che variano a seconda del contenuto
di ferro e della durata di cottura.

di AGORDO, d' ANVERSA, di ERCOLANO, d' INDIA, INGLESE, di NORIMBERGA, di PERSIA, POMPEIANA, di POZZUOLI, di PRUSSIA, di SARDEGNA, SINOPIA, di SPAGNA, VENEZIANA, di VERONA.

GIALLO di CROMO
che con la calce si trasforma in cromato rossastro.
sotto questo nome si comprendono tutti i rossi artificiali a base di ferro, cioè il ROSSO di BERLINO, INDIANO, INGLESE, di MARTE, di NAPOLI, PERSIANO e REALE.
solfuro di cadmio, CdS, con buona resistenza alla luce. In uso dal 1850. Per la sua delicata e costosa preparazione è facile trovarlo sofisticato.

ROSSO
di CADMIO scuro
solfuro di cadmio, CdS, con buona resistenza alla luce. In uso dal 1850.
Per la sua delicata e costosa preparazione è facile trovarlo sofisticato.

MINIO
(Arancio minerale, Rosso di Parigi, Rosso di Saturno), ossido di piombo
Pb3O4 minerale usato fin dall'antichità in tutte le tecniche. Nel Medioevo
fu usato a fresco, ma annerisce.
CINABRO
(o vermiglione), solfuro di mercurio, HgS, allo stato naturale, da cui si
ricava il mercurio. Citato da Teofilo (XII sec.) come componente degli incarnati
a fresco, ma ha scarsa resistenza, annerisce. Si trova su alcuni affreschi
del Quattrocento, ma dato a secco con tempere. Poiché è una tinta affascinante
gli affreschisti stentano a rinunciare ad essa: alcuni dicono che la qualità
cinese è più sicura, altri lo usano dopo immersione nell'acqua di calce
calda (ma perde molto del suo colore).
PAGONAZZO
citato dal Cennini che lo dice ricavato dall'ametista e buono per l'affresco.
Vasari lo sconsiglia mentre il Sorte dice che si possono ottenere nel fresco
i bei toni purpurei della robbia.
VERZINO
colorante fornito dalla pianta omonima. Cennini dice che per l'affresco
va macinato assieme alla polvere di vetro, ma di fatto non resiste.
(Verde di Montagna naturale, Verde Ungherese) minerale carbonato idrato del rame, usato dalle epoche più remote fino al sec. XIX. Il primo rinvenimento murale è nei dipinti della cattedrale di Verden in Germania (sec. XI). Oggi è in commercio un prodotto artificiale, ma poco stabile.
bel verde caldo, coprente, proposto dalla ditta Vasconetto di Treviso
(Talco zoografico) silicato di ferro, varia a seconda dei componenti sali di potassio, magnesio e alluminio. Assai variabile, a seconda delle località di estrazione, da un verde opaco con sottotono bluastro a un verde intenso con sfumature giallastre. Particolarmente pregiata la T.V. di VERONA, cavata a Brentonico sul Monte Baldo.

composto di una parte di nero e due parti di ocra con eventuale aggiunta di sangiovanni, suggerito dal Cennini per fondi di incarnati o di paesaggi.
V. RINNMANN, V. SVEDESE ossido di zinco e ossido di cobalto CoO+2ZnO proposto da Rinnmann nel 1870. Verde bluastro con scarso potere coprente. Si chiama anche V. di ZINCO, ma con questo nome c'è pure un composto di giallo di zinco + blu di Prussia non adatto all'affresco.
idrossido di cromo, Cr2O(OH)4, in produzione dalla metà dell'Ottocento, chiamato anche VERDE SMERALDO o VIRIDIO.
C'è il tipo OPACO e il tipo TRASPARENTE L'OPACO è ossido di cromo anidro, Cr2O3, in uso dalla metà dell'Ottocento; Il TRASPARENTE è ossido di cromo idrato, Cr2O3-2H2O, in uso dalla seconda metà dello Ottocento. Molto affine al Verde Guignet, è chiamato anche VERDE SMERALDO.

Con questo nome si trovano definiti: il VERDE GUIGNET o VIRIDIO il VERDE OSSIDO di CROMO TRASPARENTE il VERDE SMERALDO "DOLCI", che è una miscela di azzurro cobalto + un giallo sintetico il VERDE SCHWEINFURT o di PARIGI, questo però non è adatto per l'affresco.
VERDE
SMERALDO TRASPARENTE
prodotto a Parigi nel 1930.
VIOLA
di COBALTO
E' di tre tipi:
- fosfato di cobalto Co3(PO4)2
- arseniato di cobalto Co3(AsO4)2
- miscela dei due
Conosciuto dalla seconda metà del XIX secolo. Va bene per l'affresco, come tutti i composti di cobalto.
VIOLA
di CONCHIGLIA
è ottenuto dalla frantumazione di conchiglie della "Nerina fluvialis", individuato
dal Linzi in un affresco del secolo XIII a Treviso.
VIOLETTO di MARTE
è giallo di Marte molto calcinato.